Questione assai rilevante è quella concernente la natura recettizia o meno della procura. E' o meno necessario, al fine del perfezionamento della procura, che la medesima venga fatta oggetto di comunicazione?; Una risposta affermativa richiede altresì l'individuazione del soggetto al quale l'atto deve essere indirizzato. Il problema appena descritto spesso viene sovrapposto all'elemento costituito dalla naturale destinazione "esterna" della procura. Essa infatti deve essere esibita (o comunicata in copia) ai terzi, allo scopo di renderli edotti circa l'esistenza del potere rappresentativo (art.
1393 cod.civ.).
Sotto questo aspetto si può precisare che l'esibizione della procura si pone
come semplice onere per i terzi (che, nel richiederla, non vogliano sentirsi successivamente opporre da parte del soggetto falsamente rappresentato l'eventuale carenza di potere rappresentativo),
ovvero come facoltà (nel senso che il terzo ha, nei confronti del rappresentante, la semplice facoltà e non l'obbligo di richiederne l'esibizione). Al riguardo è stato deciso che
non si possa parlare di obbligo neppure quando la procura abbia ad oggetto un'attività negoziale afferente a diritti reali immobiliari, per i quali cioè la forma dello scritto è prevista ad
substantiam actus (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
14215/2014).
I due aspetti non devono esser confusi. Non si può certamente concludere nel senso del conferimento di poteri rappresentativi indipendentemente da
un volontario atto del rappresentato inteso a investire il rappresentante del potere insito nella procura nota1.
In questo senso
la procura può essere considerata atto recettizio relativamente al procuratore e non con riferimento ai terzi nota2.
Questi ultimi, come spesso viene osservato dalla giurisprudenza,
hanno (dal punto di vista del rapporto tra essi terzi ed il rappresentante) la semplice facoltà e non l'obbligo di chiederne l'esibizione (Cass. Civ.,
1817/87 )
nota3. Occorre piuttosto sottolineare, per quello che interessa in questa sede, che il terzo è gravato da un
onere in ordine alla richiesta di giustificazione dei poteri rappresentativi in capo a colui che asserisce di esserne dotato. Se, in altri termini, il terzo vuole evitare di esser esposto al rischio di inefficacia dell'atto per difetto o eccesso di potere rappresentativo, domanderà a chi si afferma rappresentante di dimostrare la fonte dei propri poteri. Questo aspetto concerne
il rapporto tra il terzo ed il rappresentato .
Dal punto di vista grafico i concetti esposti relativamente al problema della giustificazione dei poteri rappresentativi possono essere rappresentati come segue:
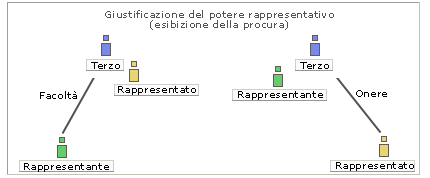
Svolte le osservazioni che precedono, è ora possibile riferire che la procura viene qualificata come
negozio giuridico unilaterale recettizio dalla dottrina prevalente
nota4 , cui fa eco la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II,
2712/91 ). In senso contrario, vi è chi ha osservato che
la procura è perfetta ed efficace non appena formata, indipendentemente dal fatto che sia stata comunicata al rappresentante nota5.Che cosa dire tuttavia nel caso in cui Tizio, nominato procuratore da Caio, senza esserne venuto a conoscenza, ponga in essere atti che sarebbe possibile perfezionare soltanto facendo uso dei poteri conferiti dalla procura (che, come si ripete, gli è ignota)?
Se si aderisse alla tesi della non recettizietà dovremmo concludere nel senso della piena efficacia dell'atto compiuto
nota6. Accogliendo invece la preferibile tesi della natura recettizia della procura, nell'esempio svolto, al contrario, non si produce per il rappresentato alcun effetto
nota7 .
Probabilmente si può concludere nel senso che in tanto la procura può ritenersi conferita, in quanto al procuratore sia stato comunicato volontariamente da parte del rappresentato il conferimento del potere rappresentativo. Qualora al procuratore pervenisse per altra via la conoscenza dell'esistenza della procura prima di questo momento si dovrebbe ritenere impossibile per il procuratore spendere efficacemente il nome del
dominus. L'esistenza di una procura non volontariamente comunicata per il procuratore avrebbe infatti la rilevanza di un mero fatto giuridico, ancora insignificante sotto il profilo negoziale
nota8 .
Note
nota1
Conforme Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.236.
top1nota2
In questo senso la dottrina prevalente (Bigliazzi-Geri, voce Procura, in Enc.dir., vol.XXXVI, p.1000, De Nova, in Sacco-De Nova, Il contratto, t.2, Torino, 1993, p.181) anche se non mancano le opinioni secondo cui il carattere di recettizietà si esplicherebbe nei confronti dei terzi: in questo ultimo senso D'Avanzo, voce Rappresentanza, in N.sso Dig.it., vol.XIV, p.807 e Minervini, in Foro it., 1947, I, p.380.
top2nota3
Analogamente Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1138.
top3nota4
Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.158; Natoli, La rappresentanza, Milano,1977, p.53 e Visintini, Della rappresentanza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p.254.
top4nota5
Così Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.101.
top5nota6
In questo senso Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.84, per il quale è sufficiente che la volontà sia stata manifestata in maniera certa (ed a questo proposito fa l'esempio di una procura rilasciata con atto notarile) per legittimare l'esercizio del potere del rappresentante, indipendentemente da una specifica comunicazione al rappresentante stesso.
top6nota7
Chianale, cit., p.1137.
top7nota8
Semmai si dovrebbe ritenere che una procura non comunicata al destinatario possa rilevare solo come indice rivelatore dell'utilità di una gestione di affari altrui, carattere dal quale dipende la nascita dell'obbligo del gestore a continuare l'attività intrapresa ed il contestuale obbligo del gerito ad indenizzare il gestore delle spese sostenute: cfr.Bigliazzi-Geri, Rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.19.
top8 Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Procura, Enc.dir., XXXVI, 1987
- BIGLIAZZI GERI, Rappresentanza in generale. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 2000
- CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
- CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
- D’AVANZO,, Rappresentanza, NDI, XIV
- DE NOVA, Il contratto, Torino, Sacco - De Nova, 1993
- GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
- MINERVINI, Foro it., I, 1947
- NATOLI, La rappresentanza, Milano, 1977
- VISINTINI, Della rappresentanza, Bologna-Roma, Comm. del c.c. Scialoja-Branca, 1993